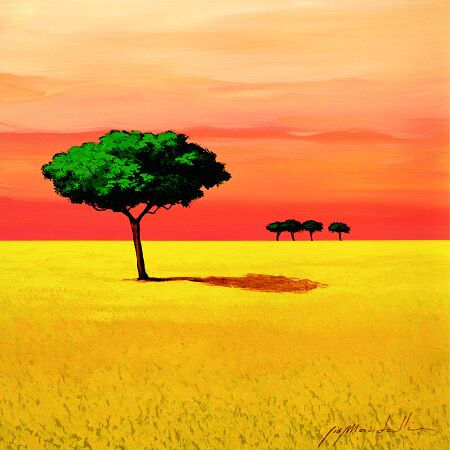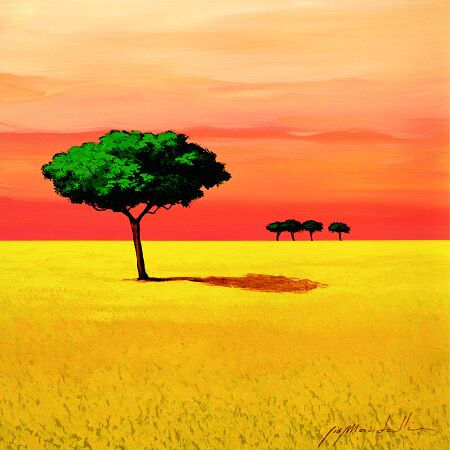|
Confessioni di un serial climber
“Vaffanculo!”.
Il simpatico saluto di
Mark Twight dalla quarta di copertina è un manifesto di
egotismo che mi
aveva a più riprese tenuto lontano dal libro. Poi una sera
alla Rock & Walls, mentre sfuggivo
all’allenamento sul Pan Gullich curiosando tra i volumi della
piccola biblioteca, Pietro tira fuori “Confessioni di
un serial climber” e mi fa: “Eccezionale,
leggilo”.
|
Le imprese di Mark
Twight: The Reality Bath, il pilone sud del Nuptse, Deprivation, parete
Rupal del Nanga
Parbat, diretta Ceca sul Denali in sessanta ore. I compagni di scalata:
Randy Rackliff, Barry Blanchard, Kevin Doyle, Ward
Robinson, Scott Backes, Steve House, Jeff Lowe. Sembra roba tostissima,
e non
stupisce che il suo manuale Extreme Alpinism sia un testo di
riferimento.
Dico subito che il dito
medio alzato in quarta di copertina si conferma essere il marchio del
libro, ma non
è una
“goliardata” gratuita: il libro non parla di
montagna, ma
di sé. Attraverso i 24 racconti che lo compongono
l’autore realizza una profonda introspezione, a tratti molto
interessante, spesso ben scritta, sempre a ritmo
sostenuto, come si fosse su una delle sue vie di ghiaccio. Di rimando,
anche il lettore
effettua la propria introspezione, e la lettura finisce quindi per
coinvolgere davvero.
Mark Twight concepisce
lo zaino a perdere: quando finisce il gas, si gettano via bombole e
fornello. “Gli
intellettuali da poltrona saranno pronti a gridare ai quattro venti la
loro ripulsa morale per questo comportamento, ma
finché critici del genere non si misureranno con la morte,
non capiranno quanto sia
facile barattare l’etica con la continuazione della propria
esistenza” (p. 220). Credo che tutti in caso di pericolo sarebbero
pronti a disfarsi dei rifiuti, ma è ben diverso prevedere di
farlo a priori come
metodologia alpinistica per scalare più leggeri! Mark Twight
scala veloce, forse in stile alpino, ma non
pulito. Anche se non lo scrive esplicitamente, si capisce che la sua
via ideale è quella con l'avvicinamento più corto
possibile, e cioè direttamente in funivia da Chamonix.
È allora il nostro turno di alzare, al riguardo, un dito
medio...
E però si fa
leggere, ed a tratti avvince. In particolare, quando ai tanti che
profetizzano “finirai per suicidarti” ribatte
“le mie migliori performance […] sono avvenute
quanto ho utilizzato l’arrampicata quale strumento per evitare il
suicidio invece che come metodo per conseguirlo” (p. 56).
C’è chi trova senso nella carriera, chi nella
famiglia, chi nella violenza contro gli altri: Twight evita la violenza
contro
sé stesso trovando senso nell’alpinismo estremo.
Al termine del tentativo sul Nanga Parbat Barry Blanchard dichiara:
“È stato come far sesso con la morte”.
Anche di
più, a leggere il racconto. Durante la micidiale ritirata, sfatti,
assiderati, uno del team grida: “Occhio che lascio le
corde”. Ed il
compagno, per tutta risposta: “Pure io”. Laconico
Twight: “Nessuno si rese conto della scomparsa delle nostre sole due corde,
né diede loro l’addio”. Si salvano
perché nel nulla trovano appeso ad un chiodo da ghiaccio uno zainetto
con dentro cibo, guanti, e due corde nuove! Anni dopo incontreranno l’alpinista
giapponese che lo aveva lasciato lì, a 6700 metri, per un
suo compagno dato disperso… Fare sesso con la morte per tenerla
lontana. Ma anche per entrare in contatto con il proprio io
più profondo, come
nel caso dell’incredibile esperienza della diretta Ceca sul
Denali (Alaska) in 60 ore. “È difficile convivere con una via del genere. Durante
quelle ore abbiamo subito una trasformazione, e ricreare quello stato di ‘consapevolezza
assoluta’ potrebbe risultare impossibile. Serbarne il ricordo
è una misera consolazione. Ho provato a raccontare e a
spiegare la fessura dalla quale abbiamo sbirciato, ma anche gli amici
più intimi
non possono capire. Quello che abbiamo imparato davvero è
racchiuso solo nei nostri cuori” (p. 227).
Gli alpinisti muoiono spesso giovani. Nel libro ricorrono delle volte
interi elenchi di amici scomparsi, delle altre singoli episodi.
“Philippe era stato mio compagno di arrampicata, e non era il
primo a perdere la
vita in montagna. Ho provato a non abituarmi a fatti del genere. Ho
analizzato con cura il suo incidente come ho fatto con gli altri. Mi
sono impegnato a farlo perché voglio vivere” (p.
61).
L’analisi che segue è lucida e spietata – come credo
sia spietata la sua voglia di vivere – e ne consiglio la
lettura a chiunque, a vario livello, frequenti la montagna,
perché c’è da imparare.
“Esistono un posso e
un non posso; non può esistere un ci provo. Starci
dentro al novantotto per cento vuol dire finire al suolo” (p.
63).
Il libro propone anche
a più riprese una riflessione sulla dicotomia via-vetta:
fare il 90% di una via dovrebbe, da 1 a 100, valere appunto 90, ed invece per le riviste
specializzate, per gli sponsor, per gli altri alpinisti, vale quasi
zero. Se è tutto quello accaduto e provato durante la via
che poi serberemo nel cuore,
perché serve la vetta per darvi senso? Serviva che Fabio
Grosso
mettesse dentro l'ultimo rigore per dare senso alla "via" effettuata
prima e durante i Mondiali Italia di calcio?
|
|
(febbraio 2007) |
|
Recensione di:
Twight, M., Confessioni di un serial
climber (2001). Tr. it. Edizioni Versante Sud, 2004.
(letto in prestito) |
|